| Pubblicato su: | Vita e Pensiero, anno IX, fasc. 5, pp. 266-276 | ||
| 261-262-263-264-265(266-267-268-269-270 271-272-273-274-275-276)277-278-279-280 |
|||
| Data: | maggio 1923 |

pag.266
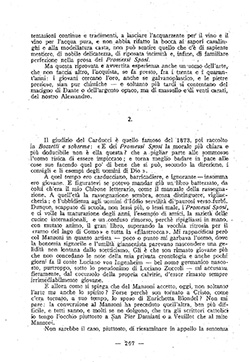
pag.267

pag.268
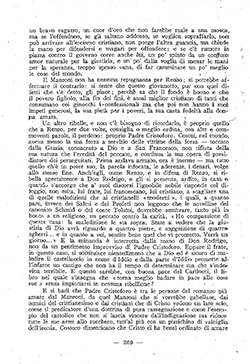
pag.269

pag.270
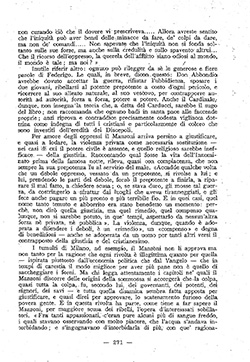
pag.271
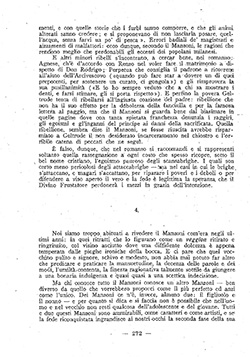
pag.272
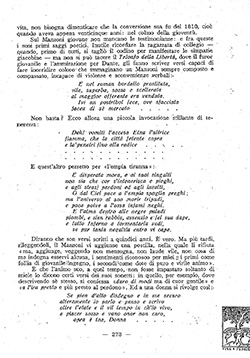
pag.273

pag.274

pag.275
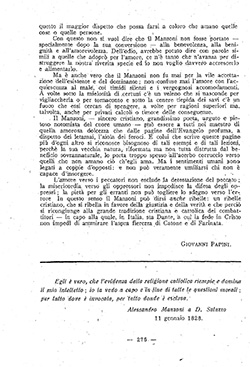
pag.276
266
Due ragioni principali mi fecero venire in uggia i Promessi Sposi da ragazzo: il doverlo studiare per l'obbligo, a scuola, col repellente contorno della famosa analisi grammaticale e logica - e il notissimo giudizio del Carducci.
Anche oggi, pur avendo cambiato l'uggia in delizia, ritengo e sostengo che i Promessi non son libro da farsi studiar nelle scuole, fuor di quelle universitarie, dove si può, o si potrebbe, andare un po' più in là della semplice lettura.
La «storia milanese del secolo decimosettimo» si può cominciare a gustarla sui trent'anni, e, meglio ancora, dopo i quaranta. Quando il ragazzo, purtroppo, è diventato uomo e ha qualche idea più precisa degli amabili uomini, suoi fratelli, tra i quali deve per forza vivere; quando, conoscendo meglio sè, e la natura politeista e dolorosamente peccaminosa ch'è in ciascuno di noi, può arrivare, con uno sforzo tanto più difficile quanto più facilmente legge negli altri, a quella disincantata indulgenza che molti prendono per amorevolezza naturale ed è, non sempre ma troppo spesso, la posatura dello scetticismo e la confessione della propria debolezza. Nel Manzoni, che spiritualmente invecchiò presto, questa lucidità di giudizio, questa umiltà di peccante in potenza, ha creato quell'atmosfera di pacatezza cordiale, quella melodia in sordina, quella finezza che finirebbe in malizia se l'occhio non fosse velato, a tempo, da un'ombra di pianto, quell'insieme di qualità, insomma, che si chiama spirito o genio manzoniano e ch'è chiuso, oscuro, se non repugnante, al giovane, il quale cerca fiducia, abbandono, impeto, affermazione.
Lo stesso per lo stile. L'arte del Manzoni è tale che uno il quale non abbia corso la cavallina della rettorica immaginifica, e non si sia innamorato e disamorato via via di tutti i modi della prosa italiana - e son più che non si creda - e non sia tornato, a poco a poco, con
267
tentazioni continue e tradimenti, a lasciare l'acquarzente per il vino e il vino per l'acqua pura, e non abbia rifatto la bocca ai sapori casalinghi e alla modellatura casta, non può sentire quello che c'è di sapiente mestiere, di nobile delicatezza, di riposata intimità e, infine, di familiare perfezione nella prosa dei Promessi Sposi.
Ma questa riprovata e avvertita esperienza anche un uomo dell'arte, che non faccia altro, l'acquista, se fa presto, fra i trenta e i quarant'anni: i giovani cercano l'oro, anche se galvanoplastico, e le pietre preziose, sian pur chimiche - e soltanto più tardi si contentano del macigno di Dante o dell'argento opaco, ma di massello e di venti carati, del nostro Alessandro.
Il giudizio del Carducci è quello famoso del 1873, poi raccolto in Bozzetti e scherme: «E dei Promessi Sposi la morale più chiara e più deducibile non è ella questa? che a pigliar parte alle sommosse l'uomo risica di essere impiccato; e torna meglio badare in pace alle cose sue facendo quel po' di bene che si può, secondo la direzione, i consigli e li esempi degli uomini di Dio».
A quel tempo ero carducciano, barricadiere, e ignorante - insomma ero giovane. E figuratevi se potevo mandar giù un libro battezzato, da colui ch'era il mio Chirone letterario, come il manuale della rassegnazione. A quell'età la rassegnazione sembra, senza distinguere, vigliaccheria; e l'ubbidienza agli uomini d'Iddio servilità di paurosi verso furbi. Dunque, scappato di scuola, non lessi più, o lessi male, i Promessi Sposi, e ci volle la maturazione degli anni, l'esempio di amici, la sazietà delle cucine internazionali, e un confuso rimorso, perchè ripigliassi in mano, con mutato animo, il gran libro, superando la vecchia ritrosia per il «ramo del lago di Como» e tutta la «filastrocca». Mi rappacificai però col Manzoni in quanto artista - poco o punto mi garbava l'uomo, dove la bonomia signorile e l'umiltà giansenista parevano nascondere una gelidità non lontana dallo scetticismo. Gli è che son rimasto giovane più che non concedano le note della mia privata crono1ogia e anche pochi giorni fa il conte Luciano von Ingenheim - bel nome germanico nascosto, purtroppo, sotto lo pseudonimo di Luciano Zucco1i - mi accusava fieramente, dal cocuzzolo della propria calvizie, d'esser rimasto sempre irrimediabilmente giovane.
E allora come si spiega che del Manzoni accetto, oggi, non soltanto l'arte ma anche lo spirito? Forse perchè son tornato a Cristo, come c'era tornato, a suo tempo, lo sposo di Enrichetta Blondel? Non mi pare: la conversione al Manzoni ha preceduto quell'altra, ben più difficile, e tutti sanno, e molti se ne dolgono, che tra gli scrittori cattolici io tengo l'occhio piuttosto a San Pier Damiani o a Veuillot che al mite Manzoni.
Non sarebbe il caso, piuttosto, di riesaminare in appello la sentenza
268
del Carducci? Dai Promessi Sposi, come asseriva il pugilista Enotrio, non si può davvero strizzare altro sugo che la rassegnazione delle vite rincantucciate?
Non mi pare: codesta, tutt'al più, potrebbe essere la conclusione che ne trarrebbe Don Abbondio, il quale non è, in fondo, odioso a Don Alessandro ma neppure può essere elevato, nel romanzo, all'ufficio che aveva il Coro nella tragedia greca. C'è una conclusione, bensì, che il Manzoni dice di far sua, mettendola in bocca ai due sposi nell'ultima pagina, e che potrebbe essere avvicinata a quell'altra: «che i guai vengono... spesso, perchè ci si è dato cagione; ma che la condotta, più cauta e più innocente non basta a tenerli lontani; e che quando vengono, o per colpa o senza colpa, la fiducia in Dio li raddolcisce, e li rende utili per una vita migliore».
Si parla qui di «guai», cioè di sventure in generale, venute per colpa nostra o d'altri, ma nulla è detto circa la condotta che l'uomo, sia pur cristiano, deve tenere quando questa sventura si chiama persecuzione o ingiustizia. Deve chinare il capo in silenzio o difendersi? E se la difesa, come purtroppo porta la miseria nostra aggravata dalle contingenze dei fatti, prende la forma di ribellione, la quale può esser somma giustizia quando è ribellione alla ingiustizia, dovremo senz'altro condannare il ribelle?
Questo problema il Manzoni non lo pone in termini precisi nel suo libro: i due santi, quelli che rappresentano meglio di tutti la grandezza e la bellezza della vita religiosa, Padre Cristoforo e Federico Borromeo parlano di «perdono», fedeli allo spirito dell'Evangelo e a tutta la tradizione cristiana. Ma se il perdono è contraccambio di amore verso chi odia, non può essere acquiescenza all'ingiustizia altrui, che diventerebbe, senz'altro, complicità nel male.
Don Rodrigo è la prepotenza della sensualità e del puntiglio: avrebbe dovuto il povero Renzo - lasciando pur dapparte le ragioni di un amore legittimo - accettare in santa pace il sopruso e andarsene dal paese perchè la sua promessa potesse senza difficoltà cadere nelle mani del persecutore?
Renzo si ribella. Vorrebbe, sul primo, ribellarsi colla violenza, e Padre Cristoforo e Lucia a gran fatica lo trattengono, e fanno benissimo. Ma la ribellione, in altri modi, ha il suo corso. Il povero Renzo tenta di difendersi e di vincere per diverse vie: prima ricorrendo alla giustizia, la quale, per la viltà dell'Azzeccagarbugli, lo respinge; poi col matrimonio di sorpresa che per la viltà di Don Abbondio non riesce.
E le ribellioni di Renzo non finiscon qui: fuggito a Milano si mescola ai facinorosi e predica in piazza e all'osteria la rivolta contro l'ingiustizie; si ribella alla legge scritta e stampata rifiutandosi di rivelare il suo nome e cognome; arrestato si rivolta ai birri e se ne libera; più tardi, durante la peste, a quelli che lo inseguono si volge con un coltellaccio in mano, «col viso più torvo e più cagnesco che avesse fatto ai suoi giorni».
Renzo, insomma, è il tipo del popolano nostro del buon tempo antico: l'uomo che ha voglia di lavorare, che pensa a metter su casa, cerca una buona moglie, è affezionato alla sposa, ai suoi, agli amici;
269
un bravo ragazzo, un cuor d'oro che non farebbe male a una mosca, ma se l'offendono, se gli saltano addosso, se voglion sopraffarlo, non può arrivare all'eroismo cristiano, non porge l'altra guancia, ma chiude la mano per difendersi e magari per offendere: e se c'è rumore in piazza contro il governo corre anche lui, un po' spinto da un confuso amor naturale per la giustizia, e un· po' dalla voglia di menar le mani per la speranza, troppo spesso vana, di far camminare un po' meglio le cose del mondo.
Il Manzoni non ha nessuna repugnanza per Renzo; si potrebbe affermare il contrario: si sente che questo giovanotto, pur con quei difetti che s'è detto, gli piace; perchè sa che il fondo è buono e che il povero figliolo, alla fin dei fini, è assai miglior cristiano di tanti che consumano coi ginocchi i confessionali ma che poi non hanno i suoi impeti generosi, la sua pietà per i poveri, la sua casta fedeltà alla donna amata.
Un altro ribelle, e non c'è bisogno di ricordarlo, è proprio quello che a Renzo, per due volte, consiglia o meglio ordina, con alte e commoventi parole, il perdono: proprio Padre Cristoforo. Costui, nel mondo, aveva messo la sua forza a servizio delle vittime della forza - toccato dalla Grazia, consacrato a Dio e a San Francesco, non rifiuta della sua natura che l'eredità del peccato, e continua la sua opera di presidiatore dei perseguitati. Prima andava armato, ora è inerme - ma tutto quello ch'è in poter suo, la parola infocata, le aderenze, i denari, volge allo stesso fine. Anch'egli, come Renzo, e in difesa di Renzo, si ribella apertamente a Don Rodrigo, e gli si presenta, ardito, in casa e quando s'accorge che a' suoi discorsi l'ignobile nobile risponde col dileggio, non esita, lui frate, lui francescano, lui cristiano, a scagliare una di quelle maledizioni che ai cristianelli «moderni», i quali, a quanto pare, invece dei Salmi e dei Profeti non leggono che le novelline del canonico Schmid o del conte Tolstoi, dovrebbe sembrare, tanto più in bocca a un religioso, un peccato contro la carità. «Ho compassione di questa casa: la maledizione le sta sopra. State a vedere che la giustizia di Dio avrà riguardo a quattro pietre, e soggezione di quattro sgherri... e in quanto a voi, sentite bene quel che vi prometto. Verrà un giorno...» E la minaccia è interrotta alla mano di Don Rodrigo, non da un pentimento improvviso di Padre Cristofloro. Eppure il frate, in questo caso, si sostituisce nientedimeno che a Dio ed è sicuro di maledire il castellaccio in nome d'Iddio e dalla parte d'Iddio promette all'infame un castigo che non ha il tempo di determinare ma che s'indovina terribile. E questo sarebbe, con buona pace del Carducci, il libro nel quale s'insegna che «torna meglio badare in pace alle cose sue» senza impicciarsi in nessuna ribellione?
E si badi che Padre Cristoforo è tra le persone del romanzo più amate dal Manzoni, da quel Manzoni che si vorrebbe gabellare, dai nemici del cristianesimo e dai cristiani che di Cristo vedono un lato solo, come il predicatore d'una dottrina di pura rassegnazione e come l'esempio del cattolico che non si lascia vincere dall'indignazione ma riduce tutte le sue armi allo zucchero, tutt'al più con un pizzichino di vaniglia dell'ironia. Costoro dimenticano che Cristo ci ha bensì ordinato di amare
270
chi ci odia, cioè chi odia noi, ma non già di accarezzare coloro che odiano il nostro prossimo, o la verità o Dio. Verso di costoro si può usare la dolcezza ma se la dolcezza non giova abbiamo il diritto, pur restando cristiani, di lasciar libera la via allo sdegno, alla condanna e, se occorre, anche all'invettiva e alla violenza. Gesù stesso, quando irrompe con tremende parole contro gli Scribi e i Farisei o mena la frusta sui Mercanti, ci ha dato un esempio che non può nè dev'essere dimenticato.
La ribellione all'ingiustizia dev'esser fatta in modo da non aggiunger male al male, e qui l'uomo per l'infermità antica è troppo spesso sottoposto ad errare, ma è un dovere preciso del cristiano, proprio di quei cristiani che si son consacrati, o sono stati consacrati, a seguitare l'opera affidata da Cristo agli Apostoli.
Ne abbiamo proprio nei Promessi Sposi, un altro esempio, e viene da colui che, più ancora di Padre Cristòforo, figura agli occhi del Manzoni la perfezione della vita cristiana, dal Cardinal Borromeo. Due colloqui lunghi troviamo nel romanzo dove Federigo parla come il grande e puro cuore gli detta: quello, famosissimo, coll'Innominato e l'altro, meno celebre, con Don Abbondio. A me, può darsi che sbagli, è sempre piaciuto di più il secondo, ~ anche ora, dopo averlo riletto infinite volte, non posso fare a meno, quando ci torno, di sentirmi intenerito e commosso. Confesso che son quelle l'uniche pagine di tutto il libro che mi hanno fatto venir le lagrime agli occhi, specialmente alla fine. Anche il dialogo coll'Innominato è bellissimo, ma lì, qualche volta, anche per la natura stessa dell'avvenimento - un gigante del male toccato dalla grazia d'Iddio - Federigo cade un po' nell'oratoria sacra: c'è, in alcuni periodi, l'ombra dell'enfasi.
Nel dialogo col povero curato il linguaggio del Cardinale è sempre elevato come si conviene alla dignità sua e alle cose che dice, ma c'è, in più, un'accoratezza, una dolcezza, un senso di umiltà veramente eroica nella sua medesima semplicità, che commuovono, per quel potere che deriva soltanto dall'innocenza che si accusa, dalla grandezza che si abbassa.
Ma in questo meraviglioso colloquio qual'è, insomma, il rimprovero maggiore che il Cardinale muove a Don Abbondio? Quello d'aver accettata l'imposizione di Don Rodrigo, di non aver disubbidito all'ingiustizia, di non aver cercato i modi per fare il dover suo a dispetto delle minacce, di non aver preso le difese dei due poveretti, di non esser ricorso a una forza buona capace di rintuzzare le pretese di quella forza cattiva, di essersi impaurito di fronte alle minacce, di non aver fatto, infine, quello che ha dovuto fare Padre Cristoforo.
«E perchè dunque, potrei dirvi, vi siete voi impegnato in un ministero che v'impone di stare in guerra con le passioni del secolo? ...... Vedete dunque voi stesso cosa avete fatto. Avete ubbidito all'iniquità,
271
non curando ciò che il dovere vi prescriveva..... Allora avreste sentito che l'iniquità può aver bensì delle minacce da fare, de' colpi da dare, ma non de' comandi ..... Non sapevate che l'iniquità non si fonda soltanto sulle sue forze, ma anche sulla credulità e sullo spavento altrui... Che il ricorso dell'oppresso, la querela dell'afflitto siano odiosi al mondo, il mondo è tale; ma noi?».
Inutile riferir altro: ognuno può rilegger da sè le generose e fiere parole di Federigo. Le quali, in breve, dicon questo: Don Abbondio avrebbe dovuto accettar la guerra, rifiutar l'ubbidienza, sposare i due giovani, ribellarsi al potente prepotente a costo d'ogni pericolo, e ricorrere al suo alleato naturale, al suo vescovo, per contrapporre autorità ad autorità, forza a forza, potere a potere. Anche il Cardinale, dunque, non insegna la teoria che, a detta del Carducci, sarebbe il sugo del libro; non raccomanda che ognuno badi in santa pace alle faccende proprie; anzi riprova e contraddice precisamente codesta vigliacca dottrina come indegna di tutti i cristiani e particolarmente di coloro che sono investiti dell'eredità dei Discepoli.
Per amore degli oppressi il Manzoni arriva persino a giustificare, e quasi a lodare, la violenza privata come necessaria sostituzione - nei casi di cui il potere civile è assente, e quello religioso sarebbe inefficace - della giustizia. Raccontando qual fosse la vita dell'Innominato prima della famosa notte, rileva, quasi con compiacenza, che non sempre la sua prepotenza fu al servizio del male. «Accadde qualche volta che un debole oppresso, vessato da un prepotente, si rivolse a lui; e lui, prendendo le parti del debole, forzò il prepotente a finirla, a riparare il mal fatto, a chiedere scusa; o, se stava duro, gli mosse tal guerra, da costringerlo a sfrattar dai luoghi che aveva tiranneggiati, e gli fece anche pagare un più pronto e più terribile fio. E in quei casi, quel nome tanto temuto e abborrito era stato benedetto un momento: perchè, non dirò quella giustizia, ma quel rimedio, quel compenso qualunque, non si sarebbe potuto, in que' tempi, aspettarlo da nessun'altra forza nè privata, nè pubblica». La violenza, dunque, quando è adoprata a difendere i deboli, è un «rimedio», un «compenso» e degna di benedizioni - anche se adoperata da un uomo per tanti altri versi il contrapposto della giustizia e del cristianesimo.
I tumulti di Milano, ad esempio, il Manzòni non li approva ma non tanto per la ragione che ogni rivolta è illegittima quanto per quella - ispirata piuttosto dall'economia politica che dal Vangelo - che in tempi di carestia il modo migliore per aver più pane non è quello di saccheggiare i forni. Ma chi legga attentamente i capitoli ne' quali il Manzoni discorre delle origini della sommossa si accorgerà che la colpa, quasi tutta la colpa, fu, secondo lui, dei governanti, dei potenti, dei signori, dei savi - e tutta quella disamina sembra fatta apposta per giustificare, e quasi direi per approvare, lo scatenamento furioso della povera gente. E in questa rivolta ha parte, come tiene a far sapere il Manzoni, per maggiore scusa dei ribelli, l'opera d'interessati sobillatori. «Fra tanti appassionati, c'eran pure alcuni più di sangue freddo, i quali stavano osservando con molto piacere, che l'acqua s'andava intorbidando; e s'ingegnavano d'intorbidarla di più, con que' ragionamenti,
272
e con quelle storie che i furbi sanno comporre, e che gli animi alterati sanno credere; e si proponevano di non lasciarla posare, quell'acqua, senza farvi un po' di pesca». Errori badiali de' magistrati e aizzamenti di malfattori: ecco dunque, secondo il Manzoni, le ragioni che rendono meglio che perdonabili gli eccessi dei popolani milanesi.
E altri minori ribelli s'incontrano, a cercar bene, nel romanzo: Agnese, ch'è d'accordo con Renzo nel voler fare il matrimonio a dispetto di Don Rodrigo; Perpetua che consiglia il padrone a ricorrere all'aiuto dell'Arcivescovo («quando può fare star a dovere un di quei prepotenti, per sostenere un curato, ci gongola») e gli rimprovera la sua pusillanimità («E io ho sempre veduto che a chi sa mostrare i denti, e farsi stimare, gli si porta rispetto»). E perfino la povera Geltrude tenta di ribellarsi all'ingiusta coazione del padre: ribellione che non ha il suo effetto per la debolezza della fanciulla e per la famosa lettera al paggio, ma che il Manzoni si guarda bene dal biasimare in quelle pagine dove con tanta spietata franchezza denunzia i raggiri, gli egoismi e gl'inganni del principe ai danni della sacrificata. Quella ribellione, sembra dire il Manzoni, se fosse riuscita avrebbe risparmiato a Geltrude il non desiderato incarceramento nel chiostro e l'orribile catena di peccati che ne seguì.
È falso, dunque, che nel romanzo si raccomandi e si rappresenti soltanto quella rassegnazione a ogni costo che spesso ricopre, sotto il bel nome cristiano, l'egoismo pauroso degli scansabrighe. I quali son certo meno pericolosi degli attaccabrighe - ma nei casi in cui le brighe s'attaccano, e magari s'accattano, per riparare i poveri e i deboli o per difendere a viso aperto il vero e la fede è legittima la speranza, che il Divino Frustatore perdonerà i mezzi in grazia dell'intenzione.
Noi siamo troppo abituati a rivedere il Manzoni com'era negli ultimi anni: in quei ritratti che lo figurano come un veggion ritirato e ringrinzito, col visino asciutto dove una diffidente dolcezza è appena temperata dalle pieghe ironiche della bocca. E ci pare che quel vecchino pulito e signore, schivo e modesto, non abbia mai potuto far altro che predicare e praticare la mansuetudine, la decenza delle parole e dei modi, l'umiltà, contenta, la finezza ragionativa talmente sottile da giungere a una bonaria indulgenza e quasi quasi a una scettica indecisione.
Ma chi conosce tutto il Manzoni conosce un altro Manzoni - ben diverso da quello che vorrebbero proporci come il più perfetto ed anzi come l'unico. Dei Manzoni ce n'è, invece, almeno due: il figliuolo e il nonno - e per quanto si dica e si faccia non è possibile che nell'uomo e nel vecchio non resti qualcosa dell'adolescente e del giovane. Tutti e due questi Manzoni sono ammirabili, come caratteri e come artisti, e se la fede riconquistata ingrandisce ai nostri occhi la seconda fase della sua
273
vita, non bisogna dimenticare che la conversione sua fu del 1810, cioè quando aveva appena venticinque anni: nel colmo della gioventù.
Sul Manzoni giovane non mancano le testimonianze: e fra queste i suoi primi saggi poetici. Inutile. ricordare la ragazzata di collegio - quando, primo di tutti, si tagliò il codino per manifestare le simpatie giacobine - ma non si può tacere il Trionfo della Libertà, dove il furor giovanile e l'ammirazione per Dante, gli fanno scriver versi capaci di fare inorridire coloro che immaginano un Manzoni sempre composto e compassato, incapace di violenze e sconvenienze verbali:
E nel roman bordello prostituta,
vile, superba, sozza e scellerata
al maggior offerente era venduta.
Ivi un postribol fece, ove sfacciata
facea di sè mercato . . . . .
Non basta? Ecco allora una piccola invocazione stillante di tenerezza:
Deh! vomiti l'accesa Etna l'ultrice
fiamma, che la città fetente copra
e là penetri fino alla radice . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
E quest'altro pezzetto per «l'empia tiranna»:
E disperata mora, e ai suoi singulti
non sia che cor s'intenerisca e pieghi,
e agli strazi perdoni ed agli insulti,
O dal Ciel pace a l'empia spoglia preghi;
ma l'universo al suo morir tripudi,
e poca polve a l'ossa infami neghi.
E l'alma dentro alle negre paludi
piombi, e sien rabbia, assenzio e fel sua dape,
e tutto Inferno a tormentarla sudi,
se pur tanta nequizia entro vi cape.
Diranno che son versi scritti a quindici anni. È vero. Ma più tardi, rileggendoli, il Manzoni vi aggiunse una postilla, nella quale li rifiuta «ma, aggiunge, veggendo non menzogna, non laude vile, non cosa di me indegna esservi alcuna, i sentimenti riconosco per miei; i primi come follia di giovanile ingegno, i secondi come dote di puro e virile animo».
E che l'animo suo, a quel tempo, non fosse impastato soltanto di miele lo dicono certi versi dei suoi sonetti: in quello, per esempio, dove descrivendo sè stesso, si confessa «duro di modi ma di cuor gentile» e «a l'ira presto e più presto al perdono». Ed a una donna si rivolge così:
Se pien d'alto disdegno e in me securo
alteramente io parlo e penso e scrivo
oltre l'etate e il vil tempo in ch'io vivo,
e piacer sozzo e vano onor non curo,
opra è tua, Donna . . . . .
274
Il Carme in morte di C. Imbonati è sempre citato, anche dai manzoniani dolci, come testimonianza dello spirito nobile e retto del Manzoni, e giustamente. Ma non si debbono ricordare soltanto i famosi e bellissimi precetti dell'Imbonati («sentir, riprese, e meditar» ecc.) ma anche le confessioni che fa il giovane poeta de' suoi propri sentimenti.
Nè del mio secol sozzo io già vorrei
rimescolar la ietida belletta
se un raggio in terra di virtù vedessi
cui sacrar la mia rima.
Nè va lasciata in ombra la pittura, tutt'altro che amabile, che del mondo umano traccia l'ombra dell'Imbonati:
Dove il pensier da la parola 'è sempre
altro, e virtù per ogni labbro ad alta
voce lodata, ma nei cor derisa;
dov'è spento il pudor; dove sagace
usura è fatto il beneficio, e brutta
lussuria amor; dove sol reo si stima
chi non compie il delitto; ove il delitto
turpe non è, se fortunato; dove
sempre in alto i ribaldi, e i buoni in fondo.
Dura è pel giusto solitario, il credi,
dura, e pur troppo disugual, la guerra
contra i perversi affratellati e molti.
Anche questi versi, si dirà, sono anteriori alla conversione. Ma son posteriori le strofe del Marzo 1821 dove s'invoca, contro gli oppressori stranieri, l'ira d'Iddio:
Se quel Dio che nell'onda vermiglia
chiuse il rio che inseguiva Israele,
quel che in pugno alla maschia Giaele
pose il maglio ed il colpo guidò . . . .
Ch'è proprio il Dio dell'Antico Testamento, il Dio delle battaglie e delle vendette che guida la mano dell'omicida.
E la stessa ira, giusta e santa, contro gli oppressori è perfino nel dolcissimo canto che accompagna la fine di Ermengarda:
Tu dalla rea progenie
Degli oppressor discesa,
Cui fu prodezza il numero,
Cui fu ragion l'offesa,
E dritto il sangue, e gloria
il non aver pietà,
Te collocò la sua viva
sventura in fra gli oppressi
. . . . . . . . . . . . . . .
Agli oppressi andò sempre la simpatia del Manzoni e questa simpatia
275
non può mai esser scompagnata, in un cuor generoso, dall'indignazione contro gli oppressori e da questa indignazione non è difficile passare all'indulgenza verso le necessarie ribellioni. E non è senza significato che il Manzoni vecchio dedicasse l'ultime forze a un'apologia della Rivoluzione italiana, la quale è da lui considerata superiore a quella francese perchè dette, e non tolse, libertà ai cittadini. Se quella francese non fosse trascesa agli eccessi delittuosi che la rendono illegittima agli occhi del Manzoni, ben altro, credo, sarebbe stato il suo giudizio, perchè egli non combatte in principio le rivoluzioni, che riconosce in determinati casi necessarie, ma i mezzi che i rivoluzionari francesi adottarono per giungere al loro fine.
Proprio nei tempi che stava pensando e preparando il romanzo il Manzoni raccoglieva anche materiali ed appunti per una terza tragedia, e anzi stendeva il canovaccio degli atti - e questa tragedia avrebbe avuto come eroe quello che da tutti i ribelli fu rettoricamente celebrato come il simbolo dell'insurrezione contro l'ingiusto dominio: Spartaco. Tutto preso dagli Sposi promessi lasciò andare Spartaco e non ne fece di nulla, ma il fatto stesso che abbia pensato ad un tale argomento e ad un tale protagonista dimostra che lo spirito del Manzoni non era tutto quanto occupato dai sentimenti che consigliano e accompagnano la rassegnazione.
Il Manzoni, spirito critico e inclinato assai più che non si creda al paradosso, non fu mai, se ben si guarda, col partito dominante, ma sempre all'opposizione. Fu all'opposizione in letteratura difendendo il Romanticismo quando imperavano i gusti, i poeti e i pregiudizi neoclassici - fu all'opposizione in filosofia, abbracciando le idee del Rosmini, - fu all'opposizione in politica, vagheggiando l'unità d'Italia e le istituzioni liberali in tempi di servitù e di assolutismo; - fu all'opposizione in fatto di lingua sostenendo, contro l'esercito purista, la necessità di rifarsi dal toscano parlato. Da ultimo, non sapendo più a chi altro opporsi, polemizzò con sè stesso in quel suo discorso sul Romanzo Storico col quale par che voglia contraddire all'ammirazione degli italiani per il suo capolavoro.
Fu, nelle sue opposizioni, prudente ma la prudenza ha, molto spesso, altri motivi che la rassegnazione. L'arma sua, quando volle condannare e combattere, fu l'ironia, ma l'ironia è tutt'altro che amorevolezza ed è più tremenda, per chi la capisce, della sfuriata. Chi s'infuria riconosce implicitamente che l'avversario è forte e temibile, altrimenti non vi sarebbe bisogno di tanto digrignar di denti e di tanto clamore. Ma l'ironista mostra, in fin de' conti, di far poca stima di colui che gli sta dinanzi: sei talmente meschino, par che dica, che non val la pena neanche d'alzar la voce e darti importanza. Basta il sorriso, ma in quel sorriso c'è tanto disprezzo! E l'odio, in confronto al disprezzo, è una mezza adulazione.
Colui che adopra l'ironia è, in fondo, ottimista rispetto all'intelligenza del suo lettore - chè non tutti capiscono l'ironia e specie quand'è fine come quella manzoniana - ma, in compenso, è severamente pessimista circa il valore delle persone o delle cose colpite, che da quella medesima apparente pacatezza viene abbassato e mortificato - ed è
276
questo il maggior dispetto che possa farsi a coloro che amano quelle cose o quelle persone.
Con questo non si vuol dire che il Manzoni non fosse portato - specialmente dopo la sua conversione - alla benevolenza, alla benignità e all'amorevolezza. Dell'odio, avrebbe potuto dire con parole simili a quelle che adoprò per l'amore, ce n'è tanto che n'avanza per distruggere la nostra riverita specie ed io non voglio davvero accrescerlo e alimentarlo.
Ma è anche vero che il Manzoni non fu mai per la vile accettazione dell'esistente e del dominante; non confuse mai l'amore con l'acquiescenza al male, coi timidi silenzi e i vergognosi accomodamenti. A volte sotto la mielosità di certuni c'è un veleno che si nasconde per vigliaccheria o per tornaconto e sotto la cenere tiepida dei savi c'è un fuoco che essi cercan di spengere, a volte per ragioni superiori ma, talvolta, anche per privati calcoli o timore delle conseguenze.
Il Manzoni, - sincero cristiano, grandissimo poeta, arguto e pietoso notomista del cuore umano - può essere a tutti noi maestro di quella amorosa dolcezza che dalle pagine dell'Evangelo profuma, a dispetto dei letamai, l'aiola dei feroci. E colui che scrive queste pagine più d'ogni altro si riconosce bisognoso di tali esempi e di tali lezioni, perchè la sua vecchia natura, riformata ma non tutta distrutta dal beneficio sovrannaturale, lo porta troppo spesso all'acerbo corruccio verso quelli che non amano ciò ch'egli ama. Ma i sentimenti umani sono legati a coppie d'opposti: e non può veramente umiliarsi chi non è capace d'insorgere.
L'amore verso i peccatori non esclude la detestazione del peccato; la misericordia verso gli oppressori non impedisce la difesa degli oppressi; la pietà per gli erranti non può togliere lo sdegno verso l'errore. In questo senso il Manzoni può dirsi anche ribelle: un ribelle cristiano, che si ribella in favore della giustizia e della verità e che perciò si ricongiunge alla grande tradizione cristiana e cattolica dei combattitori - in capo alla quale, in Italia, sta Dante, !a cui la fede in Cristo non impedì di ammirare l'aspra fierezza di Catone e di Farinata.
◄ Indice 1923
◄ Vita e Pensiero
◄ Cronologia